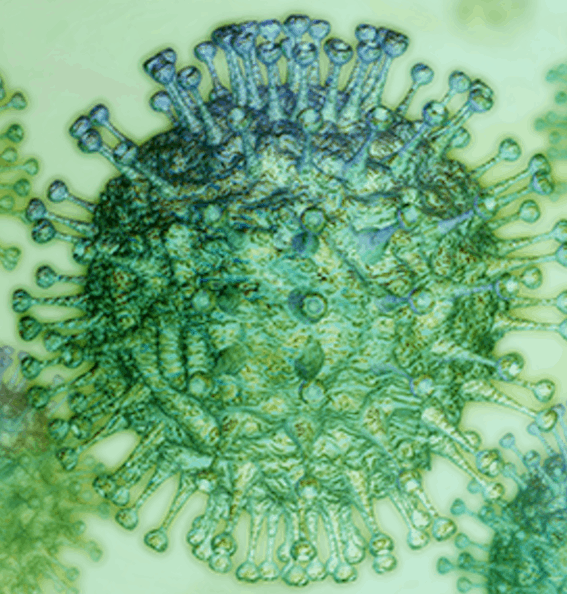

Medici e infermieri dei reparti di terapia intensiva e rianimazione sono oggi nell’occhio del ciclone. Lavorano quasi sempre in condizioni disperate: ospedali sovraffollati, mancanza di letti e respiratori, a volte la necessità di scegliere a chi garantire le cure di sopravvivenza, il tutto reso ancor più difficile dalle misure di protezione che rendono difficile ogni contatto ravvicinato non indispensabile con i malati e con le loro famiglie.
I media parlano di eroi e c’è sicuramente eroismo in chi quotidianamente rischia la propria salute per curare gli altri, si sottopone a turni estenuanti e sa in partenza che le possibilità di guarigione sono limitate: una lotta disperata e spesso disperante.
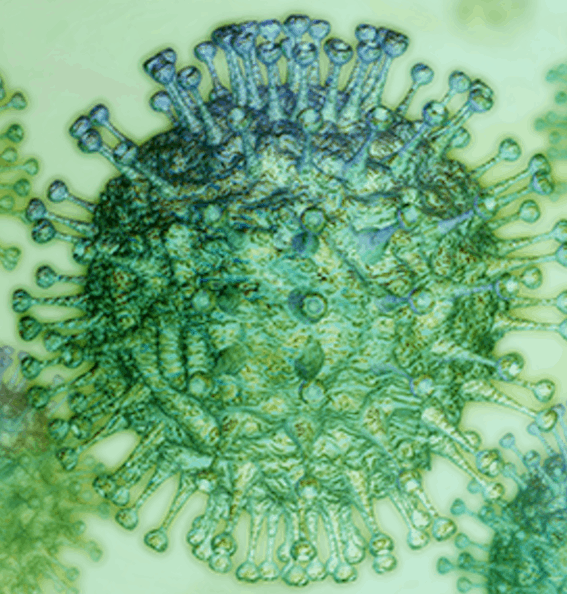
“Per noi è una sofferenza” racconta il Professor Roberto Fumagalli, Direttore del Dipartimento di Anestesia e Terapie Intensive dell’Ospedale Niguarda di Milano. “Da una dozzina d’anni insieme ai medici e agli infermieri del mio reparto ci siamo prodigati per umanizzare la nostra specialità, che è una delle più tecnologiche. Nel nostro reparto i malati sono spesso addormentati, supportati da macchine: contatti, emozioni, sentimenti non venivano presi in considerazione, anzi, si creava in molti di noi un senso direi di onnipotenza: la vita e la morte nelle nostre mani”.
Poi il prof. Fumagalli conosce Roberto Malacrida. Malacrida ha creato in Svizzera, a Bellinzona, attraverso la Fondazione Sasso Corbaro, una scuola di Medical Humanities, che punta alla formazione di personale medico e paramedico con sensibilità agli aspetti psicologici ed etici nel rapporto con i pazienti e le loro famiglie.
Medical Humanities è difficilmente traducibile in italiano. Ma si capisce subito che al centro dell’approccio di questi medici c’è il rapporto umano. “Piccoli gesti di empatia, uno sguardo, una carezza possono cambiare la vita di un malato. E il linguaggio, la gestualità, l’attenzione con cui ci si rivolge ai familiari, la condivisione delle decisioni più difficili, sono fondamentali per chi rischia di perdere la persona che ama senza neanche poterla abbracciare”.
Il professor Fumagalli, con la coordinatrice infermieristica Isabella Fontana, va con i suoi medici e infermieri a Bellinzona. Con loro trasformano il reparto, cercando di rendere l’ambiente più caldo e accogliente: una piccola libreria, schermi televisivi per distrarre e ingannare l’attesa, persino cartoni animati per i bambini. Si confrontano e condividono l’esperienza con il San Gerardo di Monza e il San Giovanni Bosco di Torino.
La terapia intensiva si apre alle visite (“prima si faceva entrare un parente alla volta, per massimo 10 minuti, ora vengono quando vogliono”), i 12 medici e i 30 infermieri incontrano spesso le famiglie in presenza della psicologa Barbara Lissoni, in una saletta dedicata nei casi più difficili. Grande è l’attenzione al linguaggio: “perché è più facile affidarsi ai termini tecnici, burocratici, disumanizzanti. Creare empatia ha un costo emotivo, ma è anche una grande ricchezza. Per i medici la morte è una sconfitta: in questi reparti il personale deve essere pronto non solo ad accettarla ed elaborarla, ma anche ad accompagnare i malati e le loro famiglie verso un fine vita consapevole e dignitoso”.
“Ma l’emergenza di questi mesi sembra aver vanificato tanti anni di lavoro” sospira il professor Fumagalli. “Il nostro reparto è passato da 35 posti a 100, di cui 80 per il Covid. In questa situazione c’è ben poco tempo per prestare attenzione alla psicologia. Anche perché il paziente deve stare isolato, dobbiamo scoraggiare i famigliari dal venire a trovarlo. Prima, quando il paziente si svegliava gli eravamo vicini, per stringergli la mano, fargli una carezza. Oggi diventa sempre più difficile, per la mancanza di tempo e per le misure di protezione. E non possiamo più incontrare i famigliari. Ci stiamo organizzando con i cellulari e i tablet; ma non è facile, anche perché una cosa è entrare in reparto, un’altra vedere le immagine fredde e terrorizzanti di una persona intubata. Abbiamo sostituito gli incontri fisici con telefonate quotidiane per cercare di raccontare quello che succede, costruire un rapporto, aiutare a modulare l’ansia. Ma è difficile anche per noi. Soprattutto se dobbiamo comunicare cattive notizie. Prima abbracciavamo i famigliari, piangevamo con loro. Ora che cosa possiamo fare?
Un aspetto terribile di questo virus, è che toglie la possibilità di un ultimo abbraccio, di un ultimo saluto. E anche noi dobbiamo fare i conti con la nostra impotenza”.

